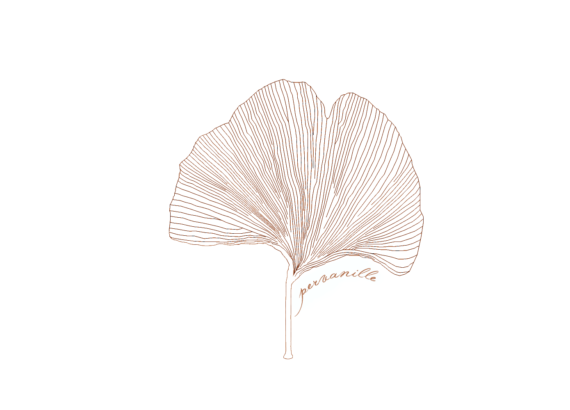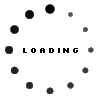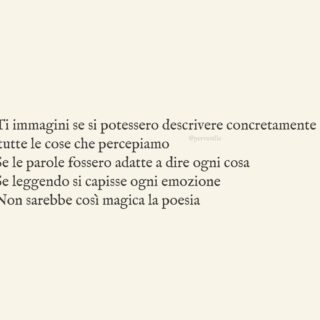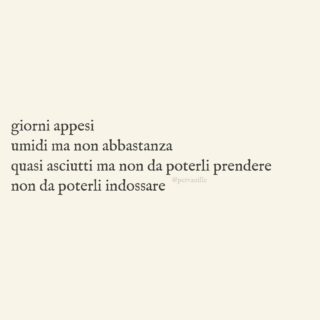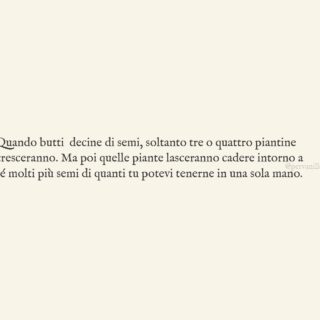Marrakech e il fumo che fa rumore

In Marocco ci è capitata una cosa strana.
Una cosa strana che sta incastrata non so bene dove, dentro di me.
In Marocco, quando siamo arrivati, l’impatto è stato forte. Non mi aspettavo di certo la pubblicità della Google o i neon di Times Square. Ma neanche quello che ci ho trovato. Quando sono scesa dal mio taxi nel bel mezzo della Medina, è come se un piccolo magma si fosse condensato al centro del petto, iniziando a pesare. Il magma di quando vedi qualcosa di strano, che ti apre uno squarcio da qualche parte. E il magma crea difesa, diffidenza. È inevitabile.
Il punto è che, quel magma, ha cominciato a sciogliersi, senza che lo volessi. Una valanga di cose, di persone. Il caos, le luci, l’umanità più vivida e multiforme, i cattivi odori, i cortili e i giardini, i colori più belli che abbia mai visto e no, non nei palazzi dei sultani, ma sui corpi della gente, nelle loro case, sui loro cuscini, nei loro piatti e nelle spezie, nell’henné, nella carne dei tanjine e nei riflessi delle candele profumate, nel tè alla menta e negli occhi dei gatti. Ma ciò che ha fatto sciogliere il magma è qualcosa che mi porto dietro. Qualcosa che non riesco a scrollarmi di dosso.
Mi porto dietro i visi e l’emozione del popolo più meraviglioso che abbia mai conosciuto. Mi porto dietro la gentilezza, quando offri più di quel che devi e la generosità, quando non si ha niente da offrire ma lo si fa lo stesso. Mi porto dietro gli occhi di Alì e di sua moglie, di Ahmed con i suoi biscottini e del commerciante berbero che ci ha mostrato tutto della sua teiera fatta a mano, pur sapendo che non l’avremmo comprata. Di Zacariah che ci ha offerto il tè e di quelli che ci salutavano e ci aiutavano a trovare la strada solo perché ci vedevano un po’ smarriti. Del tassista che continuava a dire a Marco di coprirsi perché faceva freddo fuori.
Mi porto dietro l’orgoglio di Alì, quando ci ha fatto vedere, con gli occhi lucidi, gli accessori per il tè (presina e sottoteiera nell’ultima foto) tessuti a mano dalla sorella. E ci ha detto che ha dovuto chiederle di cambiare la pallina di cotone che forma la faccia dell’omino, perché era nera e nessun turista lo voleva comprare. Le ha chiesto di farla bianca.
Mi porto dietro i bambini dei villaggi fatti di terra, dove l’elettricità è arrivata l’anno scorso, a mezz’ora dalla città, che quando hanno visto la nostra auto si sono attaccati ai finestrini gridando di gioia e non potevano proprio crederci, e correvano e si aggrappavano ovunque salutandoci, felici, e correvano ancora e non volevano perderci. Mi porto dietro lo sguardo del bambino che ha raggiunto la macchina dopo che avevamo percorso almeno cinquanta metri.
Poche volte nella mia vita mi sono sentita a casa, in un posto che non fosse casa mia. In Marocco ho lasciato qualcosa di me che ancora non riesco a trovare qui.
Il fumo della carne fa rumore e il caos è una musica che mi suona ancora nelle orecchie, nei brividi che sento quando ci penso. Ed è per tutti questi motivi che ci sentiamo un po’ vuoti. Qui è tutto troppo silenzioso.
La gente qui è più silenziosa.