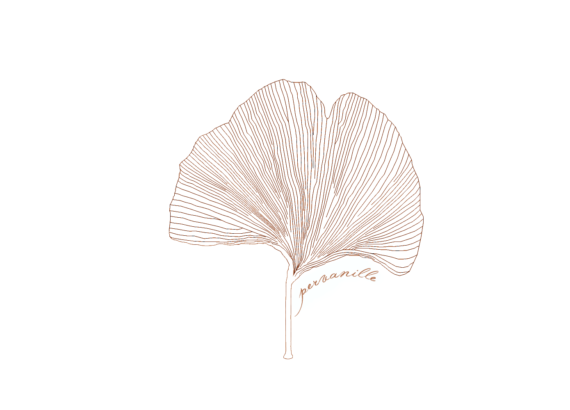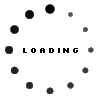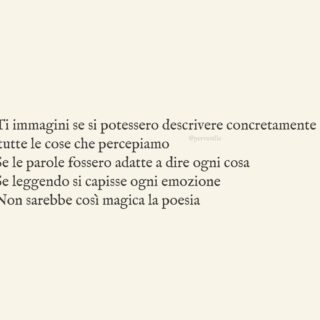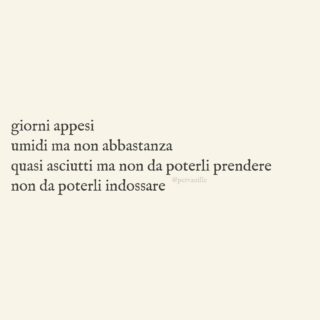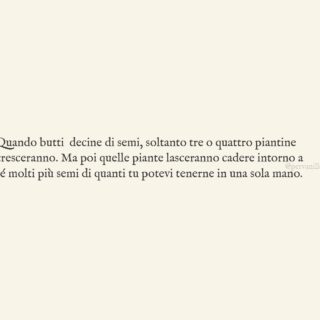La notte era scura ma quando accendevo la luce, la luce era più vera

Questa è una storia. Mia, di qualcuna, forse di molte.
Prima, quando la luce era spenta, quello che sentivo non era mai un bussare alla porta, ma dei colpi sordi, freddi, su un corpo ancora più freddo. Prima, quando tenevo la luce spenta, quando i ricordi mi gelavano il cranio, le vene, dopo una corsa, non sentivo la morbidezza dei muscoli che si rilassavano, del cuore che riprendeva il suo ritmo, ma solo la sofferenza dei polmoni vuoti e secchi, della mia bocca che quella notte provava a prendere aria in mezzo alle dita che me la tappavano. Quando avevo paura di ricordare, non era acqua per bagnare le radici, non era rugiada, ma lacrime che segnavano solchi sulla pelle. Provavo a non pensare, a non ricordare, ma all’improvviso accadeva. Accadeva mentre guardavo un film, accadeva mentre avvolgevo gli spaghetti intorno alla forchetta, mentre davo un bacio sulla fronte a mia madre. Accadeva, e allora ricordavo. Tutti i giorni e tutte le notti ci ripensavo, ma cercavo di trasformare, di cambiare il fango in terra fertile, i fulmini in lampi di luce celeste. Sotto la pelle sento ancora qualcosa, un torpore grigio e malinconico si muove anche nei giorni migliori e mi fa respirare la paura. Ingrigiscono, ogni tanto, quei lividi spariti, anche i colori dell’alba e i sapori salati del mare e dei sogni. Ingrigiscono i boschi e la freddezza della neve, il calore delle tazze di tè. Come dei fili spinati, trafiggono i pomeriggi e le notti; stille di sangue cadono lente lungo le guance, dagli occhi che ricordando, vedono. Se non amassi la vita al punto da volerla stritolare per trattenerla nelle vene, semplicemente, avrei tenuto la luce spenta.
Accendere la luce è difficile. E’ come quando hai una paura così forte che ci sia qualcuno nell’oscurità della tua camera che inizi a vedere davvero qualcosa, e quella paura si materializza, prende forma in una macchia scura. Quella macchia per me è una sera, una notte in cui non volevo chiedere l’ennesimo passaggio alla mi amica. Dovevo attraversare solo un paio di vie, la seconda a destra e poi a sinistra. Quella macchia per me non ha un volto, ma un odore, una forza contro il petto e un conato di vomito. E dopo giorni, mesi, non vuoi più sapere come è diventata quella macchia, ma lei vive lì, acquattata come una murena in una grotta pronta a scattare fuori se provi a fissarla, a stritolarti lo stomaco, e lo sento, lo stomaco, che si contorce in una morsa piena di bile e di sporcizia. E continuava a vivere lì, in un anfratto della mia camera, della mia coscienza, e io non accendevo la luce, per paura di vederla, o meglio, di sentirla. Accendere la luce è difficile, ma se lo fai, se riesci a farlo, qualcosa cambierà. E allora devi decidere di accenderla, di guardarla in faccia, quella luce, così intensamente da farti male agli occhi, tanto intensamente che gli occhi ti bruciano, ti lacrimano. Senti la voglia di distogliere lo sguardo, di portarlo di nuovo al buio, perché all’inizio, si sa, la luce è troppo forte. Ma la luce è lì e ti tiene conficcato nella sua verità e così rimani immobile, respirando piano a guardarla. Le membra intorpidite, gli occhi spalancati che sudano per carpire qualche contorno, un’immagine. Se non avessi acceso la luce, non avrei visto la macchia, non avrei visto quella notte, non l’avrei rivissuta. Ma se non avessi acceso la luce, non avrei visto neanche il resto. Non avrei visto il mondo, il mare e la neve. Non avrei visto il rosso o l’amaranto. Il rossore sul viso, il dorato di una scheggia di sole disegnata sull’erba. Non avrei rivisto la vita.
Quando ho acceso la luce, riuscivo a muovermi meglio e lo stomaco ha smesso di contorcersi. Mi sono accorta che il peso che avevo sulla pancia era terra, che le mani erano sporche. Ero stesa per terra, nella terra, e vedevo solo il cielo stellato e la luna. Era ancora notte, l’ennesima notte, ma un enorme sfera avorio e ocra mi fissava in mezzo alle stelle. Il primo tentativo di alzarmi è stato il più difficile: la terra mi bloccava la pancia, mi copriva il collo. Un odore acido e pungente mi rosicchiava le narici. Non era una terra pulita, che sa di acqua e piante sempreverdi, di cortecce umide di vita. Era un mare nero e nauseante, quello che ricopre le carcasse, una terra di vermi. A fatica, aiutandomi con le braccia ancora deboli, mi sono sollevata e, appoggiando i piedi come per paura di scottarmi, lentamente, ho avvertito l’erba. Erba umida, viva. Avvertivo il verde anche se non potevo vederlo; mi risaliva su per le gambe, come nuova linfa, fresca e dolce, e i piedi rabbrividivano per quella sensazione di morbido bagliore. Andavo ancora a tentoni perché la luce non mi sembrava più così forte e i miei occhi, rimasti al buio per tanto tempo, dovevano riabituarsi, rinascere. Come me. La solitudine però iniziava a colpirmi, ripetutamente, come un cavallone di metà luglio: i flutti mi soffocavano, mi riempivano la testa e perdevo la cognizione delle dimensioni, delle direzioni. Mi sono seduta a terra, scossa dai singhiozzi, di nuovo con gli occhi chiusi, incapaci di reagire. E’ il mondo che amavo quello intorno? E’ tutto così diverso, così nero, io sono nera, mi sento nera, sporca, ricoperta di quella terra di putrefazione. Del peccato di quella macchia. Di quella notte. Come ho pensato di farcela?
Poi, all’improvviso, un tocco. Un tocco leggero ma un boato sulla mia pelle, perché irrigidendomi sentivo i nervi, il sangue, i muscoli che respiravano di nuovo, che inghiottivano quell’aria che iniziavo a sentire più pura. Ho riafferrato la vita che stava scivolando giù, sul bagnato di quel fango. Così mi sono girata a guardare chi mi aveva sfiorata. Era un’altra donna, dolce. Aveva nello sguardo qualcosa che riconoscevo. Come me era nuda, indifesa, e completamente ricoperta di terra, la stessa terra. La terra di quello che era successo anche a lei. Di una notte come la mia, forse. O di più notti. Tutte buie, infinite. Immediatamente ho capito e ho spalancato ancora di più gli occhi: intorno a me migliaia di donne, si muovevano. Era un enorme, gigantesco prato, con ondate erbose mosse dal vento. E allora ho iniziato a sentirmi meglio perché loro erano con me. Anche vicino a loro c’era altra terra. Anche loro ne erano uscite. Alcune donne erano pulite, altre ancora più sporche. La terra di quello che ci è successo. Era la terra di un peccato senza nome, di un peccato che ci ha gettate nella fossa, ci ha sporcate, e ha spento la luce. La donna che mi aveva risvegliata mi ha mostrato una fonte e lì ho iniziato a lavarmi, e lei con me, e mentre ci lavavamo l’acqua si tingeva di nero, si sporcava di ricordi, delle notti lunghe di pianti soffocati, e con l’acqua andava via il fango nel cuore, l’odio nello stomaco, il peso che mi costringeva le gambe a terra. L’altra donna mi ha sorriso. “Sei sempre stata pulita, non hai mai avuto peccato. Sei forte quando decidi di esserlo, ma se accendi la luce, riesci a vedere che esiste il fango, ma anche che esisti tu sotto quel fango, e allora sì, allora diventi invincibile” Per la prima volta, dopo tanto, ho sorriso anche io. Un mare di buio, sconfitto dalla forza delle donne. Stava spuntando il sole e la presenza non sembrava più così tanto paurosa da non poterla affrontare. Non sarà una notte infinita, ma una parentesi nel sole; non sarà una morte, ma solo una rinascita. Era finalmente giorno.
La notte era scura ma quando accendevo la luce, la luce era più vera.
(Questo brano è stato concepito e scritto per l’evento “To be brave – donne, storie di coraggio e di una nuova vita davanti”, performance di danza e lettura a favore della lotta contro la violenza sulle donne)